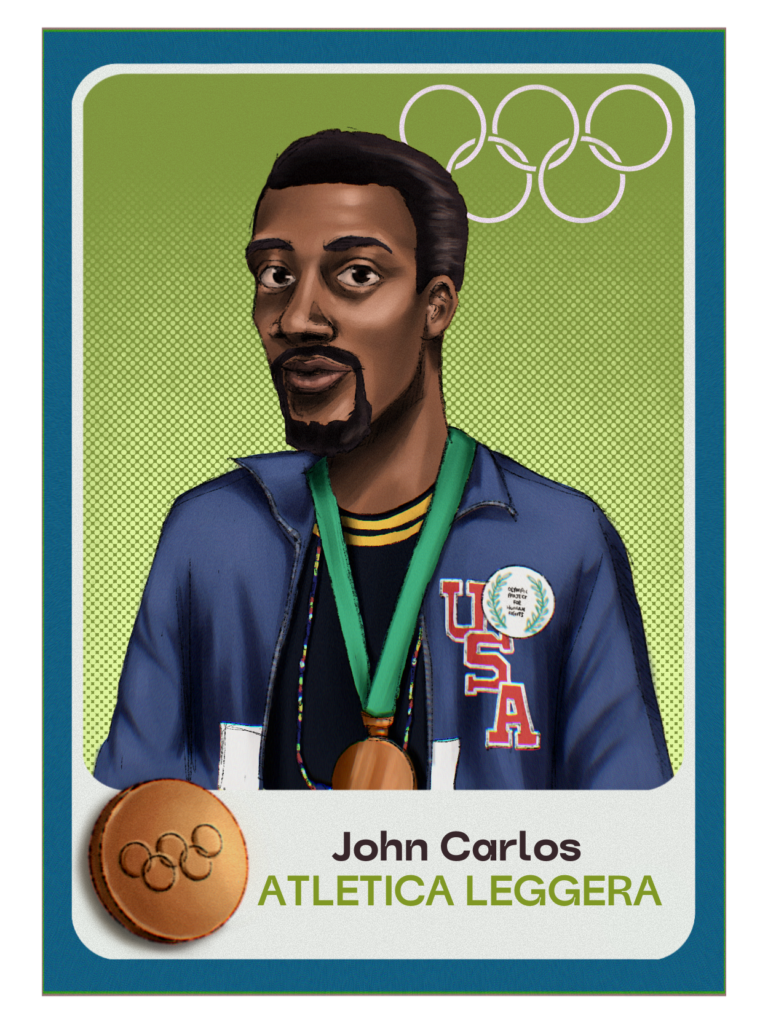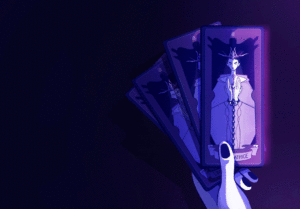Negli Stati Uniti il tema del razzismo, con le lunghe battaglie per i diritti civili, e quello dello sport, con i suoi campioni e le loro storie, si sono da sempre mescolati come in nessun altro luogo al mondo. D’altra parte, l’America è un paese nel quale per lunghi decenni il mondo del lavoro e delle università sono stati appannaggio della maggioranza bianca, ed è solo attraverso lo sport che la minoranza nera è potuta emergere e far sentire, a volte fortissima, la propria voce.
Ma a quale prezzo? Negli Stati Uniti il razzismo è stato ed è tuttora il peccato originale della società su cui essi sono costituiti. Quando nel 1776 venne firmata da George Washington la dichiarazione di indipendenza dal Regno Unito c’erano, soprattutto negli stati del Sud, circa 700mila schiavi africani. Diventarono più di 4 milioni al momento dello scoppio della guerra civile, nel 1861. Finita la guerra ed abolita la schiavitù, gli stessi stati del Sud diedero il via ad un secolo di segregazionismo con le leggi Jim Crow, che rimasero in vigore fino alla loro definitiva abrogazione, avvenuta nel 1965.
LEGGI JIM CROW
Istituite localmente a partire dal 1877 e mantenute in alcuni Stati del Sud fino al 1964, le leggi Jim Crow (il nome deriva dal personaggio di una canzonetta-caricatura degli afroamericani chiamata appunto Jump Jim Crow) si basavano sulla dottrina legale denominata Separate but Equal, che giustificava e permetteva la segregazione razziale. Le leggi Jim Crow garantirono la separazione tra bianchi e (principalmente) neri ad esempio sui mezzi e nei locali pubblici, nelle scuole, nelle università e, per un certo periodo, anche nell’esercito. Vennero dichiarate incostituzionali dalla Corte Suprema nel 1954 e abrogate nel 1965.
Il razzismo si accompagna a tutta una serie di luoghi comuni sul comportamento che un uomo di colore dovrebbe, o non dovrebbe, avere. Oltre all’inferiorità congenita, si attribuiscono note caratteriali alle persone di colore che nulla hanno a che vedere con il colore della pelle. E da questo punto di vista la “campagna di sensibilizzazione”, se la si può definire così, che l’uomo bianco ha portato avanti a cavallo tra il diciannovesimo ed il ventesimo secolo ha ancora oggi un’importanza, purtroppo, fondamentale: attraverso canzoni e canzonette, detti popolari, libri e poesie, spettacoli di teatro, i bianchi hanno stabilito un’immagine dell’afroamericano che arriva fino ai giorni nostri.
Sono tanti i personaggi di fantasia che hanno contribuito ad accrescere teorie e preconcetti sulla natura dei discendenti degli schiavi africani. Sambo, il grasso e sorridente uomo di colore idealizzato come “schiavo felice” e naturalmente pigro. Lo stesso Jim Crow, il menestrello dalla faccia nera e abile nella danza che ha “insegnato” ai bianchi del nord civilizzato a vedere gli afroamericani come dei buffoni danzanti. The Savage, il terrificante e pericoloso selvaggio comparso nel celebre film Birth of a Nation del regista, un po’ fantozziano diremmo noi, David Wark Griffith, la cui immagine cruda ha per decenni giustificato atti di violenza nei confronti dei cittadini di colore in tutti gli Stati Uniti. Infine, la figura di Mamy, la figura resa famosa dal capolavoro cinematografico Via col Vento della schiava-governante, che ha giustificato per decenni lo stereotipo della “schiava felice” dedita unicamente alla crescita dei figli del padrone. Fonte:Green
Quello americano è un razzismo diffuso e radicato che, per quattro lunghi secoli, ha dunque influenzato la vita di molti americani, la loro mentalità e la loro cultura”.
Quello americano è un razzismo diffuso e radicato che, per quattro lunghi secoli, ha dunque influenzato la vita di molti americani, la loro mentalità e la loro cultura. La storia ha dimostrato e dimostra ancora oggi come nascere afroamericano negli Stati Uniti significhi nascere cittadino di serie B, e nemmeno le vittorie, i successi personali, in certi casi il talento smodato, possono proteggere qualcuno dallo stigma di essere ritenuto dalla propria società un cittadino inferiore. Gli eventi di questo 2020, con l’omicidio di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis, le rivolte scoppiate per le strade delle città statunitensi sotto la bandiera Black Lives Matter e le controversie relative alla campagna di rielezione del presidente uscente Trump, dimostrano non solo come la civiltà statunitense non sia stata in grado di risolvere il problema razziale, ma anzi come questo sia arrivato ad un punto di scontro apparentemente irrisolvibile.
Lo sport, se da un lato è da sempre stato una potentissima arma di emancipazione sociale, dall’altro ha messo ancor più in evidenza gli stereotipi sociali”.
Lo sport, se da un lato è da sempre stato una potentissima arma di emancipazione sociale, dall’altro ha messo ancor più in evidenza come gli stereotipi sociali possano modellare in maniera decisiva la vita delle persone e il destino di intere comunità: le carriere di molti sportivi afroamericani di eccellenza infatti sono state decise dal colore della loro pelle e dagli attributi che ad essa si davano. Eppure nell’arco degli ultimi decenni ci sono state delle figure chiave nello sport che hanno deciso di non scendere a compromessi con una società che li trattava a tutti gli effetti come inferiori. Chi ha deciso di alzare la testa spesso non ce l’ha fatta, a riprova che uno stereotipo è ben più di un luogo comune, bensì un muro quasi impossibile da sfondare. Queste sono le storie di uomini e donne che hanno deciso di provare a sfondare questo muro, compiendo gesti che hanno finito per cambiare in maniera inesorabile le loro vite, e le vite altrui.
Believe in something.
Even if it means sacrificing everything.
Fin dall’inizio del ventesimo secolo la minoranza afroamericana degli Stati Uniti ha eletto alcuni tra i propri atleti più rappresentativi a simbolo di un’intera comunità: pugili, atleti olimpici, giocatori delle principali leghe professionistiche.
Dai pugni alzati di Tommie Smith e John Carlos a Città del Messico al ginocchio a terra di Colin Kaepernick in piena Trump-era, sono tante le storie di ragazzi che, a volte con un gesto e a volte con una dichiarazione, hanno messo a rischio la propria carriera in nome della giustizia sociale. Finendo spesso per pagare a carissimo prezzo il proprio coraggio. Qui una carrellata, assolutamente non esaustiva, dei personaggi principali che hanno segnato la storia (ai quali andrebbero aggiunti tanti altri, come Rubin Carter, il pugile che ha ispirato la storia di Hurricane, o i grandi giocatori di basket Bill Russell e Kareem Abdul-Jabbar, i primi professionisti afroamericani della NBA a prendere posizioni politiche nette in favore dei diritti civili).
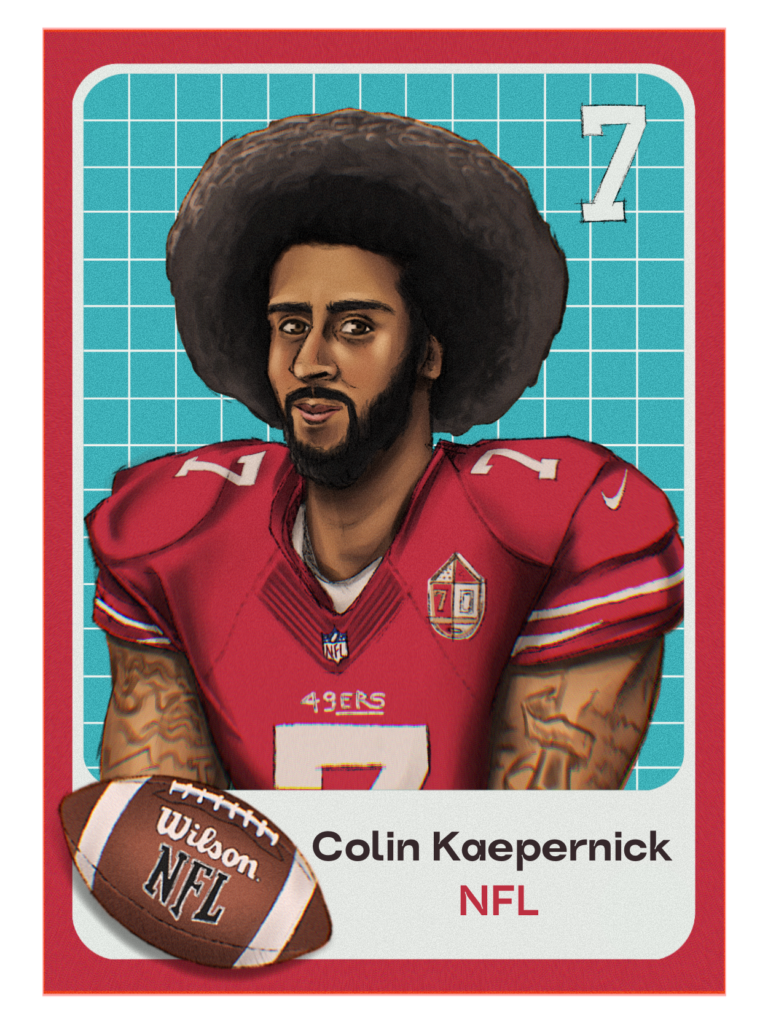
Non mi alzerò in piedi per onorare la bandiera di un Paese che opprime i neri e tutte le persone di colore. This is bigger than football. Continuerò a stare dalla parte degli oppressi. Per me è qualcosa che deve cambiare”.
Colin Kaepernick
Non possiamo sapere cosa passasse per la testa a Colin Kaepernick durante il pomeriggio del 1 settembre 2016, quando decise di inginocchiarsi durante l’inno Americano Star Spangled Banner poco prima dell’inizio della partita tra la squadra di football di cui era quarterback, i 49ers di San Francisco, e i San Diego Chargers. È facile però pensare che il quarterback, già finalista dell’edizione 2013 del Super Bowl perso contro i Baltimore Ravens, non immaginasse che quel semplice gesto durante l’esecuzione dell’inno nazionale avrebbe di fatto sancito la fine della sua carriera agonistica.
Non un contesto come un altro, quello dell’esecuzione di Star Spangled Banner prima di una partita di NFL. Il football americano è, sportivamente parlando, quanto di più americano ci possa essere. Uno sport che rappresenta in maniera quasi plateale alcuni dei principi sui quali la civiltà statunitense è stata costruita: la conquista, da parte di uomini resi irriconoscibili da uniformi e caschi tutti uguali, del territorio nemico, yard dopo yard, centimetro dopo centimetro, tanto per citare Al Pacino in Any Given Sunday. Quasi tutti i luoghi comuni su cui si basa l’immagine dell’America trovano nel football un suo specchio fedele: la disciplina, l’ordine, lo stare nelle regole, sono elementi fondamentali per far parte della lega più importante. Inoltre, il football NFL è considerato lo sport più “patriottico” tra tutti: basti pensare che l’inno nazionale viene suonato all’inizio di ogni partita, che ogni Superbowl è condito dalla presenza di ex Presidenti e che ogni anno la lega rende omaggio ai militari americani con una ricca serie di iniziative benefiche. Fonte:Pellecchia
Al netto nel football ci sono ragazzi giovanissimi, di cui il 70% neri, mandati al massacro (il 99% dei giocatori di football professionistico della NFL soffre di encefalopatia cronica cerebrale) Fonte:Mez nel nome di un bene comune più grande, rappresentato dalla vittoria di squadra.
Chiamato post partita a rispondere del suo kneeling, Kaepernick dirà: non mi alzerò in piedi per onorare la bandiera di un Paese che opprime i neri e tutte le persone di colore. This is bigger than football. Continuerò a stare dalla parte degli oppressi. Per me è qualcosa che deve cambiare. Fonte:Wyche
Continuerà naturalmente a giocare, Kaepernick. Ma solo fino alla fine di quella stagione. Dopodiché, scaduto il contratto, mancato il rinnovo, chiusa la carriera.
LA CARRIERA DI COLIN KAEPERNICK
Per chi volesse saperne qualcosa in più su Colin Kaepernick, stiamo parlando di un quarterback d’élite: californiano cresciuto sportivamente all’università del Nevada, è figlio di padre afroamericano e madre caucasica. La separazione dei genitori prima della sua nascita, convincerà la madre a dare il proprio figlio in adozione a una coppia di bianchi già genitori di due figli.
Grande talento sportivo, al liceo gioca con grande successo a basket e a baseball oltre che a football, lo sport che poi sceglie di fare suo al momento del passaggio al college. Riceve però una sola proposta di alto livello, quella appunto di University of Nevada a Reno, Nevada, quella definitiva. Da quel momento è un mietere successi uno dietro l’altro, fino alla chiamata numero 36 del Draft NFL del 2011 da parte dei San Francisco 49ers, con cui gioca quindi tutta la sua breve carriera.
Quarterback atipico, abbina caratteristiche da regista puro (ottimo passatore, eccellente visione di gioco) a una fisicità debordante, che gli permette di mettere a ferro e fuoco le difese avversarie con corse imprendibili. Un tipo di quarterback molto in voga oggi, ma assai raro fino a 15 o anche 10 anni fa. La migliore stagione appunto quella che lo porta al Super Bowl del 2013, al secondo anno di carriera tra i professionisti e al primo da titolare. Un exploit da superstar che gli permette di essere proiettato tra i grandi protagonisti dello sport più popolare degli States. Altre quattro stagioni di altissimo livello, pur senza raggiungere risultati di squadra notevoli, e poi quel fatidico 1 settembre 2016.
Il periodo durante il quale Kaepernick decide di iniziare la sua protesta non è casuale. In piena campagna elettorale per le presidenziali USA, il futuro Mr. President Donald Trump cavalca da subito e alla grande il gesto di Kaepernick, facendone una questione di “rispetto” e affidando (come sempre) a Twitter i suoi pensieri: Se un giocatore vuole il privilegio di guadagnare milioni nella NFL o in qualunque altra lega, a lui o a lei non dovrebbe essere permesso di non rispettare la nostra Bandiera e dovrebbe stare in piedi durante l’inno. Altrimenti, YOU’RE FIRED. Trovati altro da fare!
Giocando sul claim del suo celebre reality show The Apprentice, Trump decide di mettere subito in chiaro da che parte stare: le prese di posizione da parte di un uomo di sport non sono ben accette, a meno che manifestino patriottismo e retorica. Un modo di vedere le cose piuttosto popolare, soprattutto negli ambienti di una certa destra repubblicana.
DESTRA REPUBBLICANA
Una posizione simile la prenderà due anni più tardi, nel 2018, anche la nota giornalista di Fox News Laura Ingraham quando, con tono assai acido e sprezzante, commenterà il passaggio di un’intervista delle stelle della NBA LeBron James e Kevin Durant (our Country is not run by a great coach) Fonte:Letourneau con un infastidito Shut up and dribble!, letteralmente “taci e palleggia”.
Oggi Kaep è riconosciuto a tutti gli effetti come un attivista politico, prima ancora che come (ex) giocatore di football. È un uomo che è stato disposto a perdere tutto ciò che aveva, almeno da un punto di vista professionale (da un punto di vista puramente economico il ruolo di brand ambassador per la multinazionale Nike gli garantisce introiti simili a quelli di un contratto da giocatore professionista), pur di non rinunciare alle proprie idee e convinzioni. Colin Kaepernick è oggi ciò che viene definito more than an athlete. Fonte:Coates Ha fatto diventare il proprio messaggio qualcosa di più, si è esposto in maniera netta, sia nella lotta per i diritti civili che in politica, è sopravvissuto alla fine della sua carriera agonistica andando oltre, diventando un esempio per milioni di persone che in migliaia di piazze in tutto il mondo protestano ancora oggi nella maniera più pacifica possibile: un ginocchio a terra, le braccia incrociate sul ginocchio, il campo chino.

Jack Johnson
In principio fu Jack Johnson, The Galveston Giant. Primo grande peso massimo afroamericano della storia e campione del mondo tra il 1908 e il 1915, e primo nella storia e demolire, a suon di pugni, le convinzioni suprematiste secondo le quali un nero non solo non avrebbe mai potuto competere con un bianco, ma non ne avrebbe neanche mai avuto il diritto.
In piena Jim Crow Era Jack Johnson diventa, per la maggioranza bianca degli States, un simbolo negativo da abbattere ad ogni costo. Alto, forte, ricco. Grazie alla boxe vive, da nero, la vita dei bianchi: guida automobili veloci, socializza con chi vuole, gode addirittura della compagnia delle donne bianche (ne sposerà tre). Un precursore dello star system del ventesimo secolo in un’epoca segnata dalla segregazione e dal razzismo fatti legge.
In quegli anni il movimento per i diritti civili, infatti, è ancora ben lontano dal far sentire la propria voce (se ne parlerà solo a partire dagli anni Sessanta) e il principio del separate but equal giustifica, anche da un punto di vista legislativo, la segregazione razziale.
SEGREGAZIONE RAZZIALE
Benché teoricamente liberati dalla schiavitù in seguito alla fine delle guerra di secessione nel 1865, ai freedman è praticamente impedito votare da una combinazione di fattori: tasse piuttosto alte sul voto, test di alfabetizzazione e prove di comprensione di testi scritti. Dal 1890 al 1910, tutti gli stati ex confederati approvano modifiche alle proprie costituzioni che sanciscono una segregazione pressoché totale, e poiché la stragrande maggioranza della popolazione nera vive ancora in questi stati, l’intera comunità afroamericana si vede nuovamente ai margini della civiltà statunitense.
È in questo difficile contesto sociale che emerge la figura di Jack Johnson. Durante il combattimento del secolo contro la “grande speranza bianca” James Jeffries disputato nel 1910, Johnson vince e dà ad una minoranza, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, la speranza e la consapevolezza non solo di poter essere uguale all’uomo bianco, ma di poterlo anzi sfidare e battere. Sul ring come per la strada. La vittoria di Johnson su Jeffries darà infatti il là a marce spontanee da parte della popolazione nera, finalmente consapevole di poter essere in grado di cambiare, seppur di poco, la propria posizione sociale.
Sarà lo stesso Johnson a pagare a carissimo prezzo questi primi e significativi passi da parte della popolazione afroamericana verso l’autodeterminazione. Messo ai margini del mondo pugilistico, la più crudele delle punizioni diventeranno l’oblio e il declino inesorabile: problemi vari con la legge (donne bianche e automobili veloci, di nuovo, e un processo per violazione delle Mann Act – le leggi che impedivano di portare donne oltre i confini statali per scopi e condotte immorali – a Chicago nel 1912), ostracismo da parte delle autorità sportive decise ad impedirne un salto di carriera nella boxe, la necessità di andare a combattere all’estero per mantenere il proprio tenore di vita.
Tragicamente, troverà la morte nel 1946 a bordo della propria auto, dopo che un ristorante si era rifiutato di servirlo per il colore della sua pelle. Si trasformerà in black icon solo negli anni Sessanta, grazie all’attività delle Black Panthers, e otterrà piena riabilitazione anche legislativa grazie, ironicamente, a Donald J. Trump, che gli concederà il perdono, relativamente ai fatti giudiziari di Chicago, solo nel 2018.

Non avrò stretto la mano a Hitler ma non sono nemmeno stato invitato alla Casa Bianca per stringere quella del nostro Presidente”.
Jesse Owens
Storie sportive e Storia, con la S maiuscola, si mescolano ancora di più quando parliamo di Jesse Owens. Figlio del Sud segregazionista, nato in Alabama e trasferitosi in Ohio durante gli anni della Grande Depressione, inizia presto ad eccellere nello sport tanto da guadagnarsi le attenzioni della prestigiosa Ohio State University, per la quale pratica con successo le discipline atletiche. Da lì, la convocazione alle olimpiadi del 1936, quelle di Berlino, del Führer e di Leni Riefenstahl, la famosa regista del nazismo che realizzerà, proprio durante quei giochi, il più celebre documentario sportivo della storia.
L’impatto di Jesse Owens sui giochi del ‘36 è, per usare un eufemismo, epocale. Quattro ori, uno per ognuna delle specialità praticate: 100 e 200 metri, salto in lungo, staffetta. Ciò che passerà alla storia, oltre la prestazione in pista, sarà una controversa vicenda riguardante proprio Adolf Hitler il quale, contrariato dalle eccellenti performance dell’uomo nero proveniente da Cleveland, si rifiuterà di stringere la mano al quattro volte medagliato.
WHEN HITLER MEETS OWENS
Le vicende di quei giorni raccontano che Hitler, pur lontano dalle telecamere e dai flash dei fotografi, scambia un cenno di saluto proprio con lo stesso Owens dopo la finale dei 100, quella del primo oro, riconoscendogli una sorta di rispetto che nei suoi Stati Uniti non avrebbe mai ottenuto.
Ma Hitler non è l’unico a rifiutarsi di stringere la mano a Jesse Owens. Lo stesso Owens dichiara: quando sono tornato nel mio Paese dopo tutte quelle storie su Hitler, non ho potuto comunque sedermi davanti sull’autobus, non ho potuto alloggiare dove volevo, ho dovuto ugualmente usare le entrate secondarie degli alberghi. Non avrò stretto la mano a Hitler ma non sono nemmeno stato invitato alla Casa Bianca per stringere quella del nostro Presidente. Fonte:Pellecchia
Proprio così: in piena epoca segregazionista, per il presidente Franklin D. Roosevelt, così vicino alle elezioni che avrebbero sancito il secondo dei suoi quattro mandati e così bisognoso dei voti bianchi dei sudisti, anche un semplice telegramma diretto al quattro volte campione di Olimpia avrebbe significato fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Meglio non rischiare.
Come già accaduto a Jack Johnson, anche Jesse Owens deve quindi scontrarsi con una società americana profondamente razzista. Pur riconosciuto il suo status di grande atleta olimpico, Owens dovrà scendere a compromessi per tutta la sua vita per poter sopravvivere: esibizioni di velocità contro cavalli da corsa, automobili, motociclette, cani. Esperienze al limite dell’umiliazione per un fenomeno atletico trasformato, suo malgrado, in fenomeno da baraccone, e che vedrà la propria carriera da atleta professionista stroncata già all’età di 24 anni, a causa anche dell’intervento dell’allora presidente del comitato olimpico a stelle e strisce, il dichiaratamente razzista Avery Brundage, che si opererà in ogni maniera per impedire a Owens di continuare la propria carriera.
Come per Jack Johnson, anche il pieno riconoscimento di Owens come figura di grande importanza sociale, oltre che come grande atleta, arriverà solamente postumo quando il Presidente Jimmy Carter, dopo la sua morte avvenuta nel 1980, lo definirà come l’atleta che meglio di chiunque altro ha simboleggiato le battaglie dell’uomo contro la tirannia, la povertà e la discriminazione razziale.
Tommie Smith
e John Carlos
Se si parla di immagini, nulla è più iconico e stampato nella memoria dell’immagine di Tommie Smith e John Carlos ai Giochi di Città del Messico del 1968. Il 16 ottobre di quell’anno, nello Stadio Olimpico Universitario, si corre la finale dei 200 metri piani. Imprendibile, in corsia tre, Tommie Smith stravince stabilendo il nuovo Record del Mondo: 19”83. Un tempo incredibile, la prima volta per un uomo sotto i 20 secondi netti. Terzo il compatriota newyorkese John Carlos, con il record personale di 20”10. In mezzo, quasi inaspettatamente, un australiano che corre veloce e pensa molto: Peter Norman, che toglie l’argento dal collo di Carlos per pochi centesimi.
Ma qualcosa sta succedendo, prima della premiazione. I volti di Smith e Carlos sono troppo scuri per esser quelli di due ragazzi che stanno per mettersi al collo delle medaglie olimpiche. Norman si informa, e scopre che i due statunitensi hanno intenzione di inscenare una protesta pacifica per protestare contro i soprusi che gli afroamericani continuano a subire negli Stati Uniti. Hanno un paio di guanti neri di pelle (ne useranno uno a testa, Carlos ha dimenticato i suoi al villaggio olimpico) e sotto le scarpette da corsa indossano calzini neri, simbolo della povertà degli afroamericani. In più, hanno un spilletta del movimento Olympic Project for Human Rights, che coinvolge tutta una serie di atleti interessati alle battaglie per i diritti civili. Sensibile alla protesta e deciso a far sentire la propria voce, Peter Norman si fa prestare una spilla e sale sul podio insieme ai due statunitensi. È il momento più iconico e forte della storia dei Giochi.
Tutti e tre i medagliati di quella finale finiranno col pagare a caro prezzo la loro protesta. Se per Smith e Carlos la condanna è diretta, con l’esclusione immediata dai giochi da parte del razzista e filonazista presidente del Comitato Olimpico Internazionale Avery Brundage (lo stesso personaggio che si prese la briga di stroncare nel 1936 la carriera di Jesse Owens), per Peter Norman la fine della carriera è meno diretta ma forse ancor più dolorosa: condannato di fatto all’oblio da parte della società australiana si vedrà sottratta la possibilità di partecipare ai Giochi di Monaco del ‘72, nonostante avesse a più riprese ottenuto dei tempi sufficientemente bassi da poter essere ammesso nella rappresentativa di velocisti aussie senza alcun problema. Sarà la fine della carriera agonistica: costretto a svolgere lavori di ripiego, cadrà in depressione e morirà senza che la sua figura venisse rivalutata dal governo e dalla società del suo Paese.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing.
Accanto alle storie di chi in un certo senso ha perso la propria personale battaglia dovendo rinunciare, totalmente o in parte, alla carriera sportiva, ci sono anche storie di grandissimi atleti che, nonostante tutto, sono riusciti non solamente ad imporre le proprie idee e le proprie convinzioni, ma addirittura a diventare simboli di integrazione in ogni angolo del Mondo.
Da Muhammad Ali, The Greatest, universalmente riconosciuto come il più grande atleta di ogni tempo, fino a Jackie Robinson, il giocatore di baseball che ha aperto la strada per l’integrazione degli atleti neri nelle leghe professionistiche, scopriamo le storie di chi ha vinto la propria battaglia per l’integrazione, superando gli ostacoli imposti da una società profondamente razzista e discriminatoria.

Non ho nulla contro i Vietcong. Nessuno di loro mi ha mai chiamato negro”.
Muhammad Ali
Difficile pensare di condensare in poche righe la figura di Muhammad Ali. Il pugile di Louisville, Kentucky, si può considerare a pieno titolo come l’atleta più riconoscibile e famoso di ogni tempo (a livello globale forse il solo Michael Jordan è stato ed è altrettanto noto, ma l’impatto sociale che ha avuto la stella dei Bulls per la gente della sua epoca è infinitesimale rispetto a quello di Ali).
Una figura straordinaria quella del ragazzo nato con il nome di Cassius Clay Jr. nel 1942. Campione olimpico nei mediomassimi a Roma nel 1960, ha conferma di quanto profondo e radicato il razzismo sia nel suo paese quando, di ritorno dall’Italia da campione di Olimpia, si vede rifiutare comunque l’ingresso in un ristorante a causa del colore della sua pelle. Butterà nel Mississippi la medaglia d’oro da poco conquistata per la rabbia.
Parlantina fresca e sguardo affascinante, Ali diviene celebre in tutti gli Stati Uniti e, molto presto, in tutto il mondo. Ma anziché sfruttare la propria immagine solamente a scopo commerciale, Ali consacra la sua popolarità alla difesa delle proprie convinzioni, anche se questo avrebbe potuto significare perdere tutto. Un fulgido esempio di Shut up and dribble? No, thanks.
La battaglia più dura Ali forse l’ha condotta fuori dal ring, quando, nel 1967 viene chiamato alle armi per andare a combattere una guerra ritenuta del tutto assurda. Se oggi è quasi normale pensare alla guerra in Vietnam come ad un tragico e inopportuno avvenimento storico, a metà degli anni Sessanta la quasi totalità dei ragazzi chiamati a combattere si limitava a rispondere affermativamente alla chiamata senza porsi alcuna questione. Ali, no. Rifiuta di prendere parte a quel massacro forte di una logica inoppugnabile: non ho nulla contro i Vietcong. Nessuno di loro mi ha mai chiamato negro. Fonte:Hauser In più, al contrario della maggior parte dei giovani che, contrari all’arruolamento, si rifugiavano in Canada o in Europa occidentale, Ali rimane, fortemente deciso a sfidare la chiamata alle armi. Forte, alto, bello, intelligente, gran chiacchierone, contrario alla guerra: diventa in un attimo il Nemico pubblico numero 1. Fonte:Brown
È il mese di aprile del 1967 e Ali è nel pieno dei suoi anni. Giovane ed imbattuto, il suo rifiuto a combattere in Indocina comporta per lui l’impossibilità di difendere la cintura di campione del Mondo, la rinuncia obbligata a combattere a lungo e, probabilmente, il carcere. Ma non se ne preoccupa. Come Tommie Smith e John Carlos l’anno successivo, come Colin Kaepernick decenni dopo, non si preoccupa della carriera, della gloria, dei guadagni. Sa che ciò per cui sta combattendo è molto più prezioso del successo sportivo. Davanti al tribunale militare di Houston, Texas, che lo sta giudicando, si appella con forza alla propria fede e alle proprie convinzioni: è alla luce della mia coscienza di ministro musulmano e delle mie convinzioni personali che prendo la mia posizione nel rifiutare la chiamata a essere reclutato. Fonte:Hauser
Se da una parte il rifiuto di Ali provoca una reazione molto pesante da parte dell’opinione pubblica, che conta ogni giorno decine di soldati morti, dall’altra la convinzione con la quale Ali si appella alla propria coscienza di musulmano praticante gli dà la forza per continuare la propria battaglia. Incassato l’appoggio da parte della comunità di sportivi afroamericani a Cleveland, Ali spende gli anni lontano dal ring arringando folle sempre più corpose e schierate contro il massacro vietnamita: alla fine, verrà liberato da ogni accusa nel 1971.
Questa è, per Muhammad Ali, la vittoria più importante e socialmente significativa di tutta la sua vita. E quando, più di vent’anni dopo, nell’estate del 1996, uno stanco ed ormai gravemente malato Muhammad Ali prende dalle mani della nuotatrice Janet Evans la torcia olimpica ed infiamma il braciere davanti agli 83mila del Centennial Olympic Stadium e a più di tre miliardi di telespettatori, decisamente, ha smesso da tempo di essere il Nemico pubblico numero 1.
In questo gesto iconico più di ogni altro c’è tutta la vita di Muhammad Ali, che non si cura della malattia galoppante che lo fa tremare come una foglia né dei miliardi di occhi puntati sul suo incedere incerto e barcollante, anzi. Nel suo sguardo fiero e ricco di dignità c’è un messaggio di forza e speranza per milioni di malati in tutto il mondo. The Greatest lo sa e non si nasconde, ma si fa portavoce, ancora una volta, di tutte quelle minoranze costrette all’oblio da una civiltà corrotta e discriminante.

Jackie Robinson
Se si parla di diritti civili e delle lotte ad essi legati, Jackie Robinson rappresenta per gli Stati Uniti un pioniere, il primo sportivo nero a giocare in una delle tre leghe professionistiche più importanti. Anche se la sua legacy è quella fuori dal campo di gioco.
Il suo esordio nella lega professionistica di baseball, il 15 aprile del 1947, viene indicato tutt’oggi come una delle date storicamente più importanti nella storia dei diritti civili negli Stati Uniti. Un punto di svolta assoluto: il primo uomo di colore a giocare come professionista a baseball, lo sport del popolo del ventesimo secolo.
Non saranno ovviamente tutte rose e fiori. Anzi. L’ostracismo lo accompagnerà per tutta la sua sfolgorante carriera. Ma Jackie Robinson non se ne preoccupa più di tanto. Al contrario, decide di fare della non violenza un’arma, un manifesto, al pari di Martin Luther King. Il numero 42 da lui indossato diviene così un simbolo (ritirato infatti da tutte le squadre della lega in suo onore). Ad appoggiarlo, per sua fortuna, oltre al suo manager ai Dodgers, anche il commissioner della MLB di allora, Ford Frick, che rimanderà al mittente proteste di manager avversari e minacce di sciopero da parte di alcuni giocatori: non mi importa se metà della lega sciopera. Coloro che aderiranno saranno puniti. Fonte:Pellecchia E ancora: questi sono gli Stati Uniti d’America e qualunque cittadino ha lo stesso diritto degli altri di giocare. Fonte:Pellecchia Non male, per un presidente bianco di una lega bianca di una nazione ancora soggetta alle Jim Crows Laws.
Ma ciò che farà di Robinson l’uomo del cambiamento è il suo comportamento fuori dal campo. Oltre lo sport, più dello sport, c’è la capacità da parte del numero 42 di essere non solo un simbolo, ma anche un esempio, per la sua attitudine a rifiutare lo scontro decidendo di non abbassarsi mai al livello di chi lo insultava, per la sua capacità di diventare un attivista, una voce parlante, una mente pensante. Shut up and dribble? No, thanks.
Republicans buy sneakers too
Ogni epoca storica ha avuto i propri protagonisti, e a partire dalla metà del ventesimo secolo sempre più atleti, afroamericani e non, hanno dato battaglia per i diritti civili delle minoranze statunitensi. Eppure gli anni Ottanta e gli anni Novanta hanno rappresentato un vuoto, una sorta di enorme momento di pausa durante il quale i sempre più grandi interessi economici derivanti dalle sponsorizzazioni hanno spodestato a suon di dollari idee di integrazione e giustizia.
Michael Jordan, benché riconosciuto da molti come uno dei più grandi atleti della storia dello sport, rappresenta il simbolo di quest’epoca: grande giocatore, icona pop a livello mondiale, non una singola parola in difesa dei diritti delle minoranze. Cosa è cambiato in questi trent’anni? Il mondo dello sport a stelle e strisce è pronto a tornare in campo per combattere a favore dei diritti civili?
Michael Jordan vs LeBron James
Gli anni Ottanta e Novanta rappresentano, nel mondo dello sport a stelle e strisce, l’epoca del salto definitivo da una dimensione post dilettantistica ad una dimensione professionistica a tutti gli effetti. I salari dei giocatori crescono a dismisura, nascono e si sviluppano le sponsorizzazioni e le grandi star del baseball, del football e, soprattutto, del basket, escono dai confini degli Stati Uniti diventando personaggi globali.
Michael Jordan è il primo e più importante di questi personaggi. È il primo atleta a cui un brand di scarpe da basket, Nike, dedica una linea personale e un contratto multimilionario in un periodo storico, la metà degli anni Ottanta, di enorme crescita economica. Sono gli anni del reaganismo, delle grandi liberalizzazioni dei mercati e della conseguente esplosione a livello globale di marchi come McDonald’s e Coca Cola, di cui lo stesso Jordan diventa ben presto testimonial.
Ben contestualizzato, il comportamento di MJ e il suo disinteresse nei confronti dei diritti civili risulta piuttosto comprensibile. Forse non condivisibile, dati l’enorme carisma e la straordinaria popolarità del personaggio, ma comunque pienamente accettato in un’epoca nella quale la popolarità era tutto e la possibilità di rinunciare ad una succulenta fetta di consensi e guadagni schierandosi apertamente non era minimamente da prendere in considerazione. Non colpevolizziamolo eccessivamente. Ognuno è figlio della propria epoca, e Jordan è quanto di più anni Ottanta e Novanta ci possa essere.
Oggi qualcosa sta cambiando. La nuova generazione di star dello sport ha assunto una consapevolezza diversa rispetto a quella di venti o anche solo dieci anni fa. Messo contrattualmente fuori gioco Colin Kaepernick, che non mette piede in campo dal termine della stagione NFL 2016, il testimone è stato preso da LeBron James. La superstar dei Los Angeles Lakers è oggi la voce più influente del panorama sportivo a stelle e strisce. Anche lui un more than an athlete, il nativo di Akron, Ohio, da anni ha assunto il ruolo di portavoce a livello globale della comunità sportiva afroamericana.
In un’epoca segnata dal noi contro voi dell’ormai ex presidente Trump, James non ha mai avuto alcuna incertezza nel prendere una posizione politica netta contro il tycoon newyorkese, appoggiando fin dalla sua nascita il movimento Black Lives Matter e portando con sé milioni e milioni di tifosi e social followers. Per contribuire a riportare la discussione sulle politiche sociali e sui diritti civili al centro della narrazione politica americana dopo decenni di buio.
Say her name
Non solo grandi atleti, ma anche grandi atlete hanno contribuito a cambiare il corso della storia con le loro idee e con le loro gesta. Althea Gibson, prima tennista afroamericana ammessa a un torneo del Grande Slam e vincitrice dei Championships a Wimbledon nel 1957 e nel 1958, è stata colei che ha aperto la strada per l’ingresso delle donne di colore nell’olimpo dello sport mondiale. Billie Jean King invece, tennista bianca, omosessuale, vincitrice di 39 titoli del Grande Slam tra singolo, doppio e doppio misto, è stata la prima ad assumere un ruolo da protagonista nella lotta per la parità dei generi in ambito sportivo.
Oggi il testimone è raccolto da altre sportive di primissimo livello mondiale che si battono con impegno e perseveranza per la parità dei sessi e per i diritti delle minoranze. Atlete come Serena Williams o Megan Rapinoe sono non solo icone femministe conosciute in tutto il mondo, ma vere e proprie attiviste destinate ad incidere, con il loro impegno, sulla vita di milioni di persone.

Crescendo mi è stato detto che non potevo realizzare i miei sogni perché ero una donna e, soprattutto, per colpa del colore della mia pelle”.
Serena Williams
Serena Williams da vent’anni domina il circuito mondiale del tennis professionistico, conquistando 23 titoli in singolare nel circuito dello Slam fino ad oggi.
SERENA WILLIAMS
Nella prima parte della sua vita Serena Williams è protagonista, con la sorella maggiore Venus, di una storia americana da film hollywoodiano. Nata in Michigan ma cresciuta a Compton, uno dei sobborghi più pericolosi di Los Angeles, viene ben presto introdotta al tennis dal padre Richard, coach amatoriale convinto che entrambe le sorelle debbano essere destinate ad una fortunata carriera professionistica. Serena calpesta i suoi primi campi da tennis alla tenera età di quattro anni; sono campi pubblici in cemento e Williams Sr. ha lottato, letteralmente, con una gang del posto per ottenerne l’utilizzo. L’abbandono o il disinteresse per la disciplina da parte delle sorelline non sono presi minimamente in considerazione: allenamenti sempre prima di andare a scuola e fino al calar della sera. Tutti i giorni, tutto l’anno. Inevitabilmente, le Williams crescono forti, fortissime.
Giocatrice fortissima, imbattibile, è, anche lei, more than an athlete. Da sempre attiva per annullare il gender pay gap nello sport professionistico, da anni ha spostato la sua attenzione sulla condizione femminile in generale, diventando un simbolo per milioni di donne afroamericane e non. Crescendo mi è stato detto che non potevo realizzare i miei sogni perché ero una donna e, soprattutto, per colpa del colore della mia pelle. In ogni fase della mia vita, ho dovuto imparare a difendermi e parlare. Sono stata trattata ingiustamente e, nei momenti più dolorosi, sono stata oggetto di osservazioni razziste dentro e fuori il campo da tennis. Ma oggi non riguarda me, riguarda gli altri 24 milioni di donne nere in America. Se non avessi avuto talento sarei nella loro posizione, e questo non lo dimentico mai. Fonte:Pellecchia

I’m not going to the f*****g White House!”
5.3 – Megan Rapinoe
I’m not going to the f*****g White House! A precisa domanda, precisa e stringente risposta. È il 2019 e la nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti ha appena vinto il campionato mondiale. Megan Rapinoe, co-capitana della nazionale, miglior giocatrice e capocannoniere della manifestazione, icona mondiale grazie ai suoi gol e al suo look con ciuffo rosa, dice la sua rispetto alla possibilità che la sua squadra possa marcar visita, come da tradizione, alla Casa Bianca e al suo famosissimo inquilino.
Megan, oggi 35enne, rappresenta forse più di chiunque altro il modello di attivista per i diritti civili anni Venti, ed è un esempio per il futuro del movimento: i suoi messaggi abbracciano gli argomenti più svariati, dalle lotte per la parità di genere e di salario, ai diritti della comunità LGBTQ+, di cui fa parte, fino al supporto al movimento Black Lives Matter. Gode dell’appoggio di milioni di followers ed è pienamente consapevole dell’importanza dei messaggi che i campioni dello sport possono contribuire a diffondere.
Esemplare, a proposito di messaggi, lo speech da lei pronunciato in occasione delle celebrazioni per la vittoria del mondiale di calcio 2019: dobbiamo essere migliori. Dobbiamo amare di più, odiare di meno. Dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno. Dobbiamo sapere che questa è una responsabilità di tutti. Di ogni singola persona che è qui, di ogni singola persona che non è qui, di ogni singola persona che non vuole essere qui. Di ogni singola persona che è d’accordo e di chi non è d’accordo. È nostra responsabilità rendere questo mondo un posto migliore. Fonte:Zottola